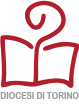LA VERITÀ SECONDO IL FIGLIO
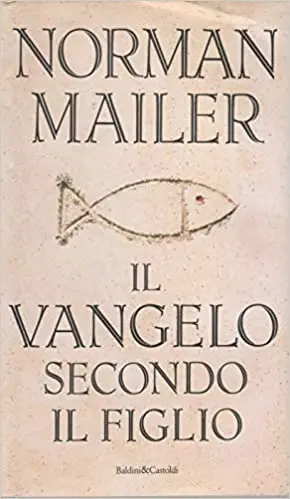
Scritto da MARIA NISII.
Il Vangelo di Marco, che non oserei definire falso, è tuttavia esagerato. E andrei ancor più cauto per quelli di Matteo, Luca e Giovanni, che mi hanno attribuito parole che non ho mai pronunciato e mi hanno descritto come mite anche quando ero pallido di rabbia. Le loro narrazioni sono state scritte molti anni dopo la mia dipartita e si limitano a ripetere quanto era stato raccontato loro da uomini anziani. Molto anziani […] Darò quindi la mia versione […] vera, perlomeno per quanto io possa ricordare (Norman Mailer, Il vangelo secondo il figlio, 1997, pp. 9-10).
Un incipit alquanto pretenzioso quello del «vangelo» secondo Mailer, autore americano di fama, ebreo di nascita, vincitore di due Pulitzer, regista di alcuni film, oltre a varie altre iniziative culturali a cui è legato il suo nome. La notorietà deve avergli fornito la giusta tracotanza per affrontare una riscrittura evangelica autenticata dal suo protagonista assoluto, al quale affida la narrazione in prima persona perché offra la sua verità screditando di conseguenza le fonti canoniche, interessate solo ad «accrescere il gregge». A questa pubblicazione Mailer offre una spiegazione: «è successo che ho riletto il Vangelo per la prima volta in cinquant’anni… E leggendo quel Vangelo [di Giovanni] prima e poi gli altri ho pensato che sì, c’erano alcuni passaggi bellissimi, ma che nel resto del libro, a chi lo legge con occhio critico, la narrazione risulta pedestre, mal scritta» (intervista di I. Bignardi su La Repubblica, 15 novembre 1997). Vediamo allora come l’autore abbia lavorato per migliorare quelle parti tanto mal scritte.
La versione autenticata fornitaci da Mailer rivela alcuni dati ignoti, quali il lavoro da apprendista nella bottega di Giuseppe («marito di mia madre», p. 12) o l’appartenenza della famiglia di Gesù agli esseni, «i più rigorosi dei Giudei nell’adorare un solo Dio, e i più sprezzanti nei confronti delle religioni dei Romani, con tutte le loro divinità» (p. 11), una necessità narrativa tesa naturalmente a spiegare il celibato di Gesù: «era raro che ci sposassimo […] mi era stato insegnato a non aver nulla a che fare con le donne […] Rispettare questa regola era legge, anche se la guerra era destinata a durare per tutta la vita» (p. 12).

«Saresti un buon falegname, se Dio avesse voluto che tu facessi questo mestiere» (p. 13), gli dice un giorno Giuseppe senza ulteriori spiegazioni. Gesù le aveva ricevute tempo addietro, ma nel frattempo le aveva perdute relegandole nell’oblio dell’infanzia: quando aveva dodici anni e con la sua famiglia tornava da Gerusalemme, Giuseppe gli aveva riferito la storia della sua nascita, ma per l’emozione il giovane Gesù ebbe un attacco di febbre e negli anni ha rimosso quel racconto fino alla morte dell’uomo che aveva creduto essere suo padre.
Degli anni della vita privata e ignota si racconta la frequentazione della scuola ebraica iniziata prima dei cinque anni, dai tredici il lavoro da apprendista garzone nella bottega di Giuseppe e dai venti l’attività di mastro carpentiere. Quest’ultima fase si conclude alla morte di Giuseppe, quando Gesù ricorda di avere un altro padre e per comprendere il da farsi sceglie di recarsi in pellegrinaggio dal cugino Giovanni il Battista, sebbene non lo conosca al di là dei racconti familiari e della fama di profeta che l’uomo si è fatta: «la prima volta ch’io lo vidi in volto, avrei voluto velare il mio. Giacché avevo capito che non sarebbe rimasto a lungo con noi» (p. 28). Di fronte al rigore del battezzatore, Gesù sente il bisogno di confessarsi, per quanto i suoi peccati siano ai suoi stessi occhi irrisori: «Scavai in me alla ricerca del male, e trovai solo il ricordo di qualche scortesia verso mia madre e qualche lotta notturna contro i cattivi pensieri. E forse talvolta ero stato poco tenero nel giudicare gli altri» (p. 29). Il battesimo è descritto come un racconto di vocazione profetica, richiamando le parole rivolte a Geremia ed Ezechiele. Ma Dio aggiunge che lui, in quanto suo Figlio, sarà più potente di qualsiasi profeta: Gesù ne è intimorito perché ha dentro di sé le immagini del Dio delle Scritture.

Invitato a recarsi nel deserto per comprendere il proprio compito, si accorge di essere protetto e insieme sottoposto a prova. Dio gli mette di fronte i peccati di Salomone e gli chiede di tenersi lontano dalle donne e da ogni ricchezza. Nelle notti di digiuno si sente in compagnia dei profeti biblici finché non arriva l’atteso visitatore. Bello e riccamente vestito, il diavolo strappa a Gesù un moto di ammirazione: «è la più bella creatura mai fatta da Dio» (p. 38). L’incontro si protrae ben oltre il racconto evangelico e l’infido tentatore si rivela notevole retore e lascivio seduttore, arguto argomentatore delle Scritture e antico conoscitore del Creatore che non teme di criticare. Gesù ne esce sfinito, ma altresì incerto di esser sfuggito del tutto alle tentazioni.
Secondo una cronologia traballante e non sempre giustificabile neppure dal punto di vista narrativo, gli episodi evangelici vengono “riordinati” dall’autore laddove sembrano meglio funzionare. Così al ritorno a Nazareth Gesù scopre che Giovanni è stato imprigionato a Macheronte e che di conseguenza è giunta la sua ora per proseguirne la predicazione. La madre invece preferirebbe che lui si unisse alla comunità essenica di Qumran, in quanto teme per la sua incolumità e non lo ritiene ancora pronto ad affrontare la vita nel mondo. Questi suoi presagi turbano il figlio, mentre giunge l’invito a un matrimonio da gente di Cana, dove Gesù mette alla prova i suoi nuovi poteri: «sul tavolo c’era un acino d’uva nera, ch’io mangiai lentamente, immerso nella contemplazione dello Spirito che in esso albergava. Sentii un angelo al mio fianco: dico davvero. In quell’istante, l’acqua delle idrie divenne vino. Sapevo che sarebbe successo. Mi erano bastati il limpido sapore di un acino e la presenza di un angelo» (p. 49). Quell’evento lo rassicura sulla tenerezza del Padre e sulla bellezza del Regno di Dio. E l’indomani lascia casa e famiglia.

Sulla strada di Cafarnao, preso dai dubbi, cade malamente salvo scoprire che è stato il Padre a spingerlo. Gesù tenta di sottrarsi al compito con le stesse giustificazioni che altri prima di lui avevano adottato e ancora una volta Dio lo invita a non preoccuparsi. Senza sapere come e perché, chiama a seguirlo due pescatori che trova sul Mar di Galilea e lo sguardo d’intesa che riceve in cambio gli fa pensare di aver ricevuto «facoltà diaboliche»: «avevo imparato a parlare alla maniera di Satana. Sapevo rivolgermi agli sconosciuti con la massima cortesia e con quella gioiosa confidenza di chi sente di avere con l’altro un’intesa fondata su molte cose mai espresse a parole» (p. 54). Per allinearsi alla versione canonica il racconto rischia spesso il ridicolo: «Simone sarebbe diventato la mia pietra. Così avevo deciso. Ben presto cominciai a chiamarlo Simon Pietro, poiché Pietro, oltre a derivare dalla parola con cui i Romani indicano la roccia, suona anche bene. E Pietro sarebbe stata la mia roccia in tutte le occasioni, tranne una» (p. 54). L’autorità con cui parla è poi superiore a scribi e farisei in quanto se gli altri leggono i rotoli con voce fievole e lamentosa, lui invece predica con voce tonante che li sovrasta.
Gesù racconta in uno stato di quasi esaltazione la facilità con cui guarisce i molti che ormai si recano da lui, ma Pietro lo avvisa: «La gente adesso ti cerca e temo che saranno in molti. Ti avverto: sono curiosi. Vogliono assister a miracoli. Ma questo ti darà il potere di cambiare le loro anime?» (p. 57). Secondo Ferdinando Castelli, questo Gesù che fa miracoli “dà l’impressione di essere un pover’uomo in cui, di tanto in tanto, si riversa la potenza di Dio” (Gesù insonnia del mondo, p. 68). Quale verità è questa millantata da Mailer?

Il romanzo si fa anche leggere, ma certo non convince. Risulta fuori luogo, ad esempio, far notare come la figlia di Giairo appena riportata in vita, non sembri molto contenta di trovarsi ancora lì. Intuizione dalla quale Gesù deduce il matrimonio infelice dei genitori e l’ambiente malsano in cui la giovinetta avrebbe vissuto. Il costante riferimento ai testi canonici non esclude naturalmente qualche impavida rimostranza: «coloro che dovevano diventare i miei scribi, e in particolare Matteo nel suo Vangelo, avrebbero parlato del mio Discorso della Montagna. Mi hanno fatto dire cose d’ogni genere, alcune in contraddizione con altre. Matteo ha messo insieme tanti detti da far pensare ch’io abbia parlato senza posa per un giorno e una notte, articolando le parole con due bocche che si ignoravano a vicenda. Posso solo riferire ciò che so: volevo comunicare a tutti loro la mia conoscenza di Dio» (p. 84). Come ci si potrebbe attendere poi non mancano le accuse ai farisei i quali, ridotti al rispetto rigoroso del precetto, diventano semplici bigotti. Con loro Gesù prova una furia che gli toglie il fiato e un avvilimento dello spirito che paragona a quello che doveva aver sperimentato Mosè nel deserto di fronte alle continue mormorazioni del popolo.
La narrazione banalizza, come spesso capita in questo genere di tentativi. Così se un giorno a Cesarea di Filippo Gesù chiede ai suoi che cosa pensi la gente di sé è perché lui stesso al mattino, svegliandosi, non sa più chi sia. Le predizioni della passione sono quindi il frutto di un sogno tormentato e la reazione dei discepoli un segno che «l’oscurità confina con l’esaltazione». Il frequente spostamento di contesto dei detti evangelici poi non è semplicemente fonte di disorientamento, che al limite potrebbe anche essere giustificato dalla struttura narrativa. Invece è la semplificazione di cui sono oggetto a ridicolizzarli. È il caso della parabola della pecorella smarrita, che serve a convincere gli undici ad attendere Levi che si è attardato a bere con gente dei quartieri bassi. Pietro però interviene sostenendo che nella realtà nessun pastore si comporterebbe in quel modo, rischiando le tante per l’una. Le parabole sono peraltro così giustificate: «La capacità di risolvere un indovinello ci faceva sentire pervasi dallo Spirito divino» (p. 100).

Inutile proseguire con la resa del racconto, che procede maldestramente fino a Gerusalemme, alla passione e morte, resurrezione compresa: «È proprio vero che al terzo giorno sono resuscitato. I miei discepoli però hanno infarcito di favole i loro resoconti». Non è improbabile che anche Mailer sia stato imbarazzato dalla quadruplice versione canonica, non ultimo di una lunga serie. Le varianti evangeliche sarebbero quindi “favole” e “tentazioni sataniche”, che la sua “verità” rimetterebbe al giusto posto. Ma non pago di questo, dopo aver bacchettato gli evangelisti, prosegue con la storia del cristianesimo, dando conto di chiese ricche e culti alla madre la quale ora è finalmente soddisfatta del figlio. Il Padre invece è sempre in lotta con il diavolo e le guerre sarebbero il frutto delle sue battaglie perse.
Una ben triste “verità” questa di Mailer, una versione di cui avremmo fatto volentieri a meno, come tante altre di cui cerchiamo di dar conto. Quando si può, si cerca di salvare qualcosa, ma qui non si saprebbe da dove cominciare: non utile a suggerire una critica costruttiva all’evangelizzazione o a fornire spunti di dialogo o magari appagare il lettore per le brillanti intuizioni narrative. Che ci si possa fregiare della parola “verità” per proporre una tale assurda accozzaglia di banalità fa venire i brividi. Verità è una parola delicata, da usare con parsimonia, timore e tremore.
Chi vanta la verità – ci ha allertato George Orwell – è suo primo manipolatore. Nel mondo distopico di 1984 infatti il Ministero della Verità si occupa di gestire la “riscrittura” di articoli e notizie perché siano conformi alla versione ufficiale. Il passato viene aggiornato, corretto né ci si può “permettere che resti traccia di notizie o opinioni in contrasto con le esigenze del momento. La storia è un palinsesto, che può essere raschiato e riscritto tutte le volte che si vuole”. E questa cos’è, fiction o verità?