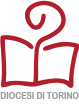Il mito di Sansone: forza e dolcezza

Scritto da MARIA NISII.
“La mia anima si rifugia sempre nel Vecchio Testamento ed in Shakespeare. Là almeno si sente qualche cosa: là son uomini che parlano. Là si odia! là si ama, si uccide il nemico, si maledice ai posteri per tutte le generazioni; là si pecca.” (Søren Kierkegaard)

Non in pochi si sono chiesti che cosa ci faccia un personaggio come Sansone tra i giudici biblici della storia di Israele (Gdc 13-16), nel periodo di mezzo tra l’insediamento nella terra promessa (Gs) e l’era monarchica (da 1 Sam). Ambiguo eroe dalla forza sovrumana e dalle passioni incontrollabili, personalità controversa che avrebbe dovuto salvare il popolo, nella sua tormentata vita Sansone compirà stragi più per vendetta personale che per questioni di identità nazionale. Parafrasando Kierkegaard, un uomo che parla – ma infrangendo l’assioma forza-brutalità, stupisce con il suo tono lirico (14,14 e 18; 15,16); un uomo che odia e uccide frotte di filistei, nemico per eccellenza del popolo; infine un uomo che ama – alla ricerca disperata di qualcuno che accetti e ami la sua diversità.
È questa l’interpretazione che ne Il miele del leone David Grossman (Rizzoli, 2005) propone, rileggendo interamente la vicenda dell’eroe biblico. La chiave di lettura sta tutta nel paradosso del titolo, che richiama uno dei primi episodi della giovinezza dell’eroe quando, recandosi dalla futura sposa filistea, squarta il leone che lo aveva assalito, per poi scoprire, nel viaggio seguente andando a sposarsi, che era diventato alloggio per un nido d’api che avevano riempito di miele parte della carcassa. In quel miele Sansone affonda le mani, ne mangia e ne prende per offrirlo ai genitori. Quella dolcezza di cui si riempie le mani e la bocca, donandola ai suoi mentre da loro si stava separando, dice la sensibilità di questo eroe, eccezionale come la sua forza e, come questa, ugualmente impenetrabile e misteriosa anzitutto a se stesso.
Sansone secondo Grossman è un uomo schiacciato e perseguitato dal peso di un destino deciso per lui “fin dal grembo materno” che ne fa un diverso, condannato alla solitudine nell’impossibilità di condividere con alcuno il suo segreto. È così che con Dalila succede l’imprevisto: lei infatti è “l’unica che abbia saputo chiedergli la cosa giusta, quasi lo esortasse ad affidare a lei il segreto che si porta dentro e per il quale le altre donne non avevano mostrato alcun interesse, o che forse temevano” (116).

Come Susanna e Betsabea, Dalila è una delle figure femminili che più ha solleticato la curiosità voyeuristica delle riscritture iconografiche. La bella traditrice sulle cui ginocchia l’eroe posa la testa in un atto di abbandono quasi infantile è modello di femme fatale e amante omicida, perfetta sintesi di eros e thanatos. Contro questa lettura tradizionale si scaglia Erri De Luca in Vita di Sansone (Feltrinelli, 2002), secondo cui Dalila non tradisce ma, al contrario, non potendo rifiutare di obbedire ai capi del popolo, predispone tacitamente con l’amante una “messinscena”, per cui “lui le rivelerà false notizie sul suo segreto, istruzioni sbagliate. Lei le eseguirà, ma non funzioneranno. Prenderanno così del tempo, ruberanno ancora giorni al loro amore” (12). A conferma di questa nuova e suggestiva ipotesi sarebbe il ritorno della forza durante la prigionia non appena gli ricrescono i capelli: i filistei certo non l’avrebbero consentito se Dalila avesse infranto il segreto. “La sentenza che fa di lui un ingenuo e di Dlilà traditrice sia pertanto derubricata a diceria e perciò annullata” (15).

Dalila è l’unica donna di questa storia ad avere un nome. La madre è inizialmente detta la “sterile” (Gdc 13,2) e poi semplicemente “donna”, la sposa filistea è “onesta ai suoi occhi” (scelgo la traduzione di Grossman al tradizionale “mi piace”, 14,5 e 7) e quanto alla prostituta di Gaza è sufficiente che Sansone la “veda e vada da lei” (16,1).
Dalila è l’unica donna ad avere un nome e non a caso è l’unica che Sansone ami: l’amore fa uscire dall’anonimato, è atto di riconoscimento dell’Altro. Ma l’amore, appunto, è anche rischio, esposizione, sacrificio, dono di sé. La madre è stata colei che ha dato un nome al figlio (13,24) e Sansone è colui che ha dato nome immortale alla donna della valle di Sorek. E sul grembo di questa donna che ama riposa infine, fondendo l’immagine di figlio-amante, prima del sacrificio estremo.
* * * * * * * *
Samson di Haendel, oratorio in tre atti, 1741 (libretto tratto da Samson Agonistes di J. Milton)