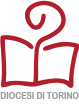Missionari, sempre in cammino

Scritto da MARIA NISII
Di piede in piede (2).
Ogni volta che padre Joseph passava di là, raccontava loro di quanto desiderasse che Dio, in aggiunta alla consacrazione delle mani, avesse previsto una qualche speciale benedizione per i piedi dei missionari. (Willa Cather, La morte viene per l’arcivescovo)
Evidentemente Willa Cather, scrittrice americana del secolo scorso, doveva avere ben presente la lode ai piedi del messaggero resa immortale dal profeta Isaia, quando descrive uno dei suoi protagonisti mentre si sta preparando per il viaggio più impegnativo della sua vita da missionario.
Padre Joseph Vaillant arriva nel Nuovo Messico perché voluto dall’amico Jean Marie Latour, nominato vescovo della nuova diocesi a metà Ottocento. La vita di missione è impervia, ma i due hanno le doti necessarie per affrontarne le difficoltà, soprattutto perché per i primi anni le vivranno insieme (li mandò a due a due) e ancor più in quanto sono tanto diversi, dunque complementari. All’eleganza naturale di Latour è infatti affiancato lo sgraziato Vaillant, brutto e dotato di un fisico gracile che parrebbe poco adatto alle asperità del luogo: «eppure persino i più rozzi meticci messicani avevano compreso all’istante il suo valore. Se il vescovo era tornato a una Santa Fe bendisposta nei suoi confronti, era perché tutti credevano in padre Vaillant – semplice, concreto, tenace, con la forza di dieci uomini in quel suo corpo così striminzito» (p. 37).
Inevitabile tornare a parlare delle doti fisiche, armamentario indispensabile per l’uomo che viaggia; eppure qui lo si fa per relativizzarle, dato che la vivacità di questo prete francese supera di gran lunga il suo aspetto dimesso. Perché allora si consacrano le mani e non i piedi, si chiede padre Vaillant, quando entrambi sono fondamentali per il ministero abbracciato? E ce lo chiediamo pure noi oggi, che viviamo in tempi accelerati, in cui non si può star fermi… Tempi in cui è oramai scomparso l’uomo di sacrestia, ingessato nella sua talare d’altri tempi, chiuso nell’ufficio parrocchiale o in confessionale in perenne attesa di penitenti… o no?

Cambiamo latitudini geografiche e storiche, facendo un salto indietro nel tempo fino al Giappone del XVII secolo, raccontato da Shusaku Endo in Silenzio (1966) e riproposto al cinema da Martin Scorsese nel 2016. Non sono pochi i punti di contatto tra le due storie, come in genere tra le tante storie di missione. Ma qui c’è la non piccola differenza che si tratta di una terra dove si rischia il martirio, perché la religione cristiana è duramente perseguitata, e fedeli e pastori mettono in pericolo la loro vita al pari dei cristiani dei primi secoli.
Di fronte all’accusa di essere adepti della religione proibita, la prova che si deve essere disposti ad affrontare (ai tempi dei primi cristiani era offrire sacrifici agli dei) è quella di calpestare il fumie, l’immagine di Cristo su una lastra di bronzo. Un’immagine che il lettore di Endo è chiamato ad accogliere nelle modalità personali, più intime e significative per la propria storia, e che il film di Scorsese rende invece con il volto del Cristo di El Greco.

https://www.youtube.com/watch?v=l6p-Dl6KdIQ
Interessante, a mio avviso, la critica che emerge nella ricostruzione del livore per il cristianesimo nutrita dal suo maggiore persecutore: «I padri ci hanno sempre messi in ridicolo. Conoscevo padre Cabral… provava solo disprezzo per tutto ciò che era giapponese. Disprezzava le nostre case; disprezzava la nostra lingua; disprezzava il nostro cibo e le nostre usanze… eppure viveva in Giappone. Neppure a quelli di noi che si sono diplomati al seminario ha concesso di diventare preti» (p. 97). Il risentimento suscitato ha assunto proporzioni enormi, ma all’origine si riconosce la mancanza di fedeltà al Vangelo in una delle tante forme dell’umana miseria.
Per spezzare la resistenza del protagonista e costringerlo all’abiura pubblica, padre Rodriguez non viene sottoposto a tortura fisica ma a indebolimento dello spirito. La sua prigionia è protratta, viene rinchiuso in un capanno al buio dopo aver assistito ai supplizi e alla morte di diversi cristiani: tutto contribuisce a intensificarne il tormento di sentirsi responsabile di tanta sofferenza. Quando infine comprende a quale supplizio sia chiamato, torna a sentire la presenza di Cristo tanto a lungo desiderata:
Signore, da molto, molto tempo, innumerevoli volte ho pensato al tuo volto. […] ogni volta che pregavo, il tuo volto mi compariva davanti; quando ero solo pensavo al tuo volto che impartiva una benedizione; quando mi hanno catturato il tuo volto, quello che avevi quando portavi la croce, mi ha dato vita. Questo volto è profondamente scolpito nel mio animo: nel mio cuore ha vissuto la cosa più bella e preziosa che esista al mondo… E adesso con questo piede io ti calpesterò. […] Vorrebbe premersi quel volto quel volto calpestato da tanti piedi. Con espressione rattristata fissa intensamente l’uomo al centro del fumie, logorato e scavato perché calpestato di continuo. […] Ora egli calpesterà ciò che ha considerato la cosa più bella della sua vita, ciò che ha ritenuto più puro, ciò che riempie gli ideali e i sogni di un essere umano. Come gli duole il piede! E poi il Cristo di bronzo gli dice: “Calpesta! Calpesta! Io più di ogni altro so quale dolore prova il tuo piede. Calpesta! Io sono venuto al mondo per essere calpestato dagli uomini! (Shusaku Endo, Silenzio, p. 183-4)
Con gli stessi piedi con cui era partito, fiducioso e timoroso per la missione, ora è costretto all’atto di abiura. I piedi gli dolgono al solo pensiero di calpestare l’immagine che gli è più cara, quella con cui ha vissuto per gran parte della sua vita. Da quell’immagine però ora arrivano parole chiare,parole che impartiscono un ordine: calpesta! Lascia che i tuoi piedi si posino sul mio volto. Ti farà male, lo so. Ma io sono venuto al mondo per calpestare le sue strade ed essere calpestato dagli uomini.

Questa è stata l’incarnazione. Prima di Vaillant e Rodriguez e i tanti missionari di tutti i tempi, anche Gesù di Nazareth ha camminato per predicare il Vangelo. Per questo ha lasciato che i suoi piedi venissero benedetti dalle cure di una donna innominata (bagnati e unti, come un sacramento!). Quel gesto però non può che scandalizzare, perché lui si lascia “toccare” da una donna (Lc), per lo spreco dell’unguento (Mc, Mt, Gv) – come se non si trovasse una ragione sufficiente e ne occorresse più d’una. Scandalizzerà infatti anche Pietro quando Gesù vorrà ripetere il gesto sui suoi amici. E continua a fare un certo effetto anche a noi oggi, quando il papa bacia i piedi ai detenuti il giovedì santo.

Non far le cose con i piedi, si diceva un tempo… Lo sappiamo, c’è sempre stata una certa svalutazione associata a questa parte del corpo…
… Generazioni hanno calpestato, calpestato, calpestato;
e tutto è arso dal commercio; offuscato, insozzato dalla fatica;
e porta lordume d’uomo e ha lezzo d’uomo: il suolo
è nudo ora, né sente il piede, essendo calzato.
Gerald Manley Hopkins, poeta e gesuita inglese vissuto nella seconda metà dell’Ottocento, scrive questi versi onomatopeici nel noto componimento La grandezza di Dio:
Generations havetrod, havetrod, havetrod
A leggerlo nella sua versione originale inglese, questo verso carico di consonanti dure, sembra di sentirli tutti quei passi che hanno ripetutamente calpestato il suolo, pieni di sudore e fatica. In un testo in cui si loda la grandezza divina, ancora una volta c’entrano quindi i piedi, di cui non si dimentica il lordume.
L’aria granulosa. Quel sapore in bocca che non se ne andava mai. Erano fermi sotto la pioggia come animali da fattoria. Poi proseguirono, tenendosi il telo sopra la testa per ripararsi da quella noiosa acquerugiola. Avevano i piedi fradici e gelati e le scarpe che cominciavano a consumarsi. Sui fianchi delle colline, vecchie messi secche e appiattite. Lungo l’arido crinale, alberi scorticati e neri sotto la pioggia. (Cormac McCarthy, La strada, Einaudi, p. 16)
Sono oltremodo lerci e infreddoliti i piedi dei due protagonisti di La strada, che si spostano in un mondo post-apocalittico, dove ci si deve continuamente spostare per sopravvivere, al punto che le scarpe diventano importanti quasi come il cibo.

I nostri piedi incarnano il moto perpetuo che ci caratterizza, il nostro istinto migratorio e istinto di sopravvivenza, il desiderio che ci spinge a superarci, a proseguire sempre qualunque meta si sia raggiunta. Anche essere cristiani comporta il mettersi in cammino, non per niente il primo nome della nuova religione è stato la “via”. Non per niente conosciamo una favolosa proliferazione di metafore che va in ogni direzione: dalla navata delle chiese alle processioni, dall’ite missa est ai pellegrinaggi…