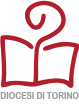MARI e MARIA

Scritto da LORENZO CUFFINI.
Poche figure, come quelle di Maria, sono state oggetto di riscritture di ogni tipo nel corso dei secoli. La Maria del Vangelo, descritta con i pochi versetti essenziali che tutti conosciamo benissimo, ha prodotto così un fiorire di Madonne di ogni tipo; da quelle Bambine alle Vergini delle Annunciazioni e fino alle Pietà; dalle rappresentazioni di umili ancelle alle Regine gloriose, in vario modo incoronate. Il fatto è che, diversamente dagli altri personaggi della Scrittura, Maria è stata protagonista di un costante e monumentale approfondimento teologico e spirituale lungo i secoli, accompagnato allo sviluppo parallelo di una radicatissima devozione popolare, pronta a cogliere alcuni aspetti di questo approfondimento, e a sottolinearne molti altri autonomamente. Su tutto, naturalmente, ha influito – e influisce come sempre – il contesto culturale, sociale e politico del momento, che si riflette anch’esso nella versione di turno data della Vergine.
Prendiamo ad esempio il caso della venerazione verso la Maris Stella.
“Tra le tempeste tu guidi il cuore, di chi ti invoca, Madre d’amore.”
E’ il verso di uno dei canti più noti della devozione popolare mariana, ed esprime bene il legame che, nel sentire cattolico comune, si è venuto a creare tra Maria, o meglio, la sua protezione, e le perigliose traversate che possono riguardare ciascuno di noi. E se l’appellativo tra i più antichi con cui la Vergine viene venerata, quello di Stella Maris, con una genesi lessicale controversa e indiretta, fa riferimento al concetto di Stella polare, cioè punto di riferimento e ferma guida per chi la cerca in alto, con il passare del tempo si è affiancato ad esso anche quello più letterale e immediato, di guida e sostegno della gente che va per mare. Questa è la ragione di una devozione particolare che ha preso piede in molte zone rivierasche, fra i pescatori, fra i viaggiatori su nave, tra chi insomma ha a che fare con la grande distesa d’acqua. Da sempre materna e amica, ma anche pronta a trasformarsi in feroce forza della natura scatenata.
Tra le tante possibili che si potrebbero indicare, ci sono tre rappresentazioni che sembrano perfette per illustrare questa interpretazione specifica data al ruolo di Maria, e i modi diversi in cui è stata declinata.

La prima viene da Valdocco, a Torino, e consiste nella raffigurazione del cosiddetto “ sogno delle due colonne “ di San Giovanni Bosco, Quello in cui il santo ebbe in visione l’immagine drammatica di una nave (la Chiesa) in mare aperto: e si tratta di acque in cui imperversa una furibonda battaglia senza esclusione di colpi. Don Bosco stesso racconta:
“Figuratevi – disse – di essere con me sulla spiaggia del mare, o meglio sopra uno scoglio isolato, e di non vedere attorno a voi altro che mare. In tutta quella vasta superficie di acque si vede una moltitudine innumerevole di navi ordinate a battaglia, con le prore terminate a rostro di ferro acuto a mo’ di strale. Queste navi sono armate di cannoni e cariche di fucili, di armi di ogni genere, di materie incendiarie e anche di libri. Esse si avanzano contro una nave molto più grande e alta di tutte, tentando di urtarla con il rostro, di incendiarla e di farle ogni guasto possibile. A quella maestosa nave, arredata di tutto punto, fanno scorta molte navicelle che da lei ricevono ordini ed eseguiscono evoluzioni per difendersi dalla flotta avversaria. Ma il vento è loro contrario e il mare agitato sembra favorire i nemici. In mezzo all’immensa distesa del mare si elevano dalle onde due robuste colonne, altissime, poco distanti l’una dall’altra. Sopra di una vi è la statua della Vergine Immacolata, ai cui piedi pende un largo cartello con questa iscrizione: Auxilium Christianorum (Aiuto dei Cristiani); sull’altra, che è molto più alta e grossa, sta un’Ostia di grandezza proporzionata alla colonna, e sotto un altro cartello con le parole: Salus Credentium (Salvezza dei Credenti).”
E’ a queste due colonne che il comandante della nave, “il Romano pontefice”, la àncora, con due catene. Dunque, in questo caso, Maria è rappresentata mentre interpreta alla lettera il suo suolo di Madre della Chiesa, di cui è stata investita ufficialmente dal Cristo in Croce, tramite l’affido incrociato con Giovanni. In più compare come Vergine immacolata ( il dogma è dell’l’8 dicembre 1854), secondo l’effige che noi vediamo ancora oggi riprodotta nelle statuine della Madonna di Lourdes ( le apparizioni sono del 1858). Il sogno è del 1860, la consacrazione della chiesa di Maria Ausiliatrice è del 1868 . La tempesta raffigurata è quella che riguarda la vita e la sopravvivenza della Chiesa stessa, e Maria è la colonna che non cede, l’ àncora cui agganciarsi per non soccombere definitivamente, l’appiglio sicuro su cui fare affidamento. Potremmo dire: una riscrittura del ruolo della Vergine ecclesiologica, mistica e politica al tempo stesso.
La seconda immagine viene invece da un altro Santuario che è nel cuore di ogni cattolico torinese, quello della Consolata, e precisamente dalla galleria in cui sono raccolti gli ex voto, un’autentica antologia di fede popolare e di devozione mariana. Qui è un vero e proprio festival dell’intervento soprannaturale di Maria, che veglia e accorre, sollecita e materna, nelle piu’ svariate circostanze e contesti. Tra i tanti spicca la rappresentazione di un naufragio.

Su uno sfondo livido e fosco, un mare in tempesta, una barchetta miseramente rovesciata su se stessa, uno spicchio d’acqua plumbeo, una nave spezzata in due, abbandonata, una scialuppa di salvataggio in primo piano travolta dalle onde, le facce terrorizzate di un gruppo di ragazzi destinati a sparire tra i flutti. Un paio di figure tra i naufraghi levano lo sguardo al cielo dove, in uno squarcio circonfuso di nubi, compare la Vergine, con il bambino in braccio. Interessante notare come qui Maria appaia sotto le sembianze specifiche della Madonna Consolata, evidentemente richiamata nel momento del massimo pericolo e della fine incombente, da una preghiera o da una invocazione d’aiuto a lei diretta.
Cambiando gli anni, i contesti e gli scenari, si arriva ai giorni nostri e ci si trova di fronte alla Maria di Porto Negato, presentata solo pochi giorni fa e che fin dal nome si collega al dramma dei profughi morti e abbandonati nel Mediterraneo.

Qui compare una Maria molto diversa dalla iconografia tradizionale. Intanto non sta in cielo o su un altare, ma a livello nostro, potremmo dire terra terra, se non fossimo in mare aperto. Non ci sono aureole, né luci di gloria, né altri segni di distinzione regale o divina. L’unico è un camminare sulle acque che pare riallacciarsi direttamente a quanto fa Gesù nella famosa pagina di Vangelo. A parte questo, ci appare semplicemente donna, madre , profuga e abbandonata tra i profughi. E’ sicuramente una Madonna con Bambino: solo che in questo caso, il suo piccolo Gesù richiama con evidenza Alan Kurdi, il bimbo siriano morto nel 2015 in un naufragio, al largo delle coste della Turchia, divenuto immagine simbolo della ecatombe di questi anni. Nella fotografia che tutti conosciamo, il bimbo è a faccia in giù sulla sabbia, con la maglietta rossa e i pantaloncini blu. Il Bambino della Madonna di Porto Negato ne riprende dunque in pieno la postura e l’aspetto. Una sorta di risarcimento postumo, la consolazione che il suo abbandono mortale ha trovato conforto eterno tra le braccia di Maria. La quale, in questo quadro, non solo è madre tra le madri, con il suo bambino in braccio, ma, con la mano libera, fa un cenno eloquente, come a richiamare chi guarda a intervenire. Il suo sguardo non è fisso all’alto dei cieli, né chino ai derelitti cui prestare soccorso: è puntato su di noi che guardiamo, come per chiamarci direttamente in causa. Sembra volere dire, direttamente e personalmente: guarda qua, cosa facciamo? Cosa puoi fare? Intorno a lei, un gruppetto di profughi in balia dell’acqua, secondo una vista divenuta tristemente familiare da tante fotografie di repertorio. Una rappresentazione che sembra tratta da un quotidiano popolare, più che suggerire un’immagine sacra. Con una suggestione potente però, e fortemente evocativa: un corpo inanimato, dipinto in primo piano, a braccia spalancate nella figura della croce, che ricorda molto da vicino il Cristo Morto di Mantegna.
Insomma. Nella prima rappresentazione, Maria è vista solennemente come Madre della Chiesa. Nella seconda, compare come Madre di Dio e Madre nostra, nostro rifugio e nostro aiuto. Nella terza, i ruoli precedenti sono presenti, ma come dati per sottintesi, mentre la sua figura sembra voler essere soprattutto un memento! vivente e una chiamata a riscuoterci. Nella preghiera che è stata composta in accompagnamento al quadro, si legge infatti:
Madre nostra, sei lì, in mare, dove annegano i tuoi figli. Ti ergi sul naufragio della nostra fratellanza come faro nella furia della disumanità, e ci mostri dove accorrere per salvare gli uomini, le donne, i bambini, per salvarci tutti. Sei lì, con loro, e avanzi verso il porto negato, a ricordarci che siamo fratelli, che dobbiamo indignarci, testimoniare la solidarietà, accogliere, rivendicare e riscattare la stessa sacralità della vita. Alla testa della schiera dei respinti, il tuo sguardo dolente ci invoca: “Fate come me, unitevi a me, insieme potete tornare a essere fratelli”».
__________________________
- Madonna di Porto Negato, di Giuseppe Martino.
- In copertina: Madonna del mare, Lampedusa