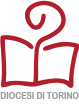«…sarebbe stato grasso». La Passione secondo Mazzacurati

Scritto da Matteo Bergamaschi
Fiorano, Toscana. Usuale Sacra Rappresentazione in occasione della Passione. A pochi minuti dall’inizio, l’attore scelto per impersonare Cristo si infortuna comicamente, e non può prendere parte all’evento. Palpabile lo scompiglio del regista, Gianni Dubois (Silvio Orlando). Tale il culmine de La Passione, film del 2010 di Carlo Mazzacurati. Si tratta di una commedia, che ospita generosamente scorci del paesaggio, delle tradizioni e dei costumi italiani, insieme agli stereotipi del mondo dello spettacolo e in generale dello star system. Al contempo, al cuore della trama, emerge un interrogativo piuttosto attuale: come si può rappresentare il personaggio di Cristo senza per questo omogeneizzarlo al mondo dello spettacolo e alle leggi dello schermo? Come rappresentare il Figlio di Dio – manifestatosi come «figlio del falegname» – senza farne un supereroe che ne snaturi il volto e lo stile? Possiamo farcene un’immagine che rimanga «icona», e non si perverta in «idolo»?
Ma torniamo al film. La scena dell’Ultima Cena è ormai allestita, il pubblico è radunato. Gli apostoli sono raccolti attorno alla tavola, quand’ecco che compare al centro la corpulenta figura di Ramiro (Giuseppe Battiston), ex-detenuto e ricercato dal disarmante accento veneto. Quest’uomo grasso e impacciato, ingenuo attore della domenica, rischia il carcere per non abbandonare al fallimento l’amico, il regista Dubois. Ma ecco che, dopo le prime battute, lo sgabello su cui siede cede sotto il suo peso, e Ramiro rovina a terra tra le risate generali, senza riuscire ad alzarsi. Lo soccorre Dubois, e tra i due avviene un commuovente dialogo: « – Sei stupendo, sei un Cristo perfetto: sei povero, sei ricercato, tutti ridono di te. – Ma sono grasso… – Anche Cristo lo sarebbe oggi, sai?».
Qui si cela il potenziale riflessivo della pellicola, di estrema attualità per le riscritture cinematografiche della storia sacra. Il corpulento attore, infatti, si riprende, e sudato e paonazzo proclama nel suo marcato accento che non c’è amore più grande che dare la vita per un amico; egli afferma di essere la via, la verità e la vita attraverso i propri discepoli (ovvero gli abitanti di Fiorano). Questa la portata veritativa della scena: l’inetto Ramiro si offre quale unica icona credibile della trascendenza evangelica. Nel mondo del successo e dell’efficienza, nell’universo dello spettacolo e dei corpi perfetti, il solo personaggio in grado di indicare in direzione di un senso «eccedente», «trascendente» simile contesto, è il fallito, l’incapace, il sempliciotto, l’uomo grasso – sinonimo moderno del povero biblico, se si vuole. Costui infatti permane nel mondo, è un elemento reale, che appare, che si dà a vedere; e tuttavia non è «appariscente» (non è «mondano»), si sottrae alla logica «immanente» dei riflettori e dello show business («Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi»), e in tal modo sprigiona un potenziale di senso in grado di indicare in direzione di un «oltre», alla volta del divino. Ciò che nel mondo non funziona, ciò che è «stolto» e «debole», «ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato», è l’icona credibile di ciò che è oltre il mondo.