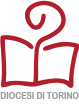Una verità bugiarda
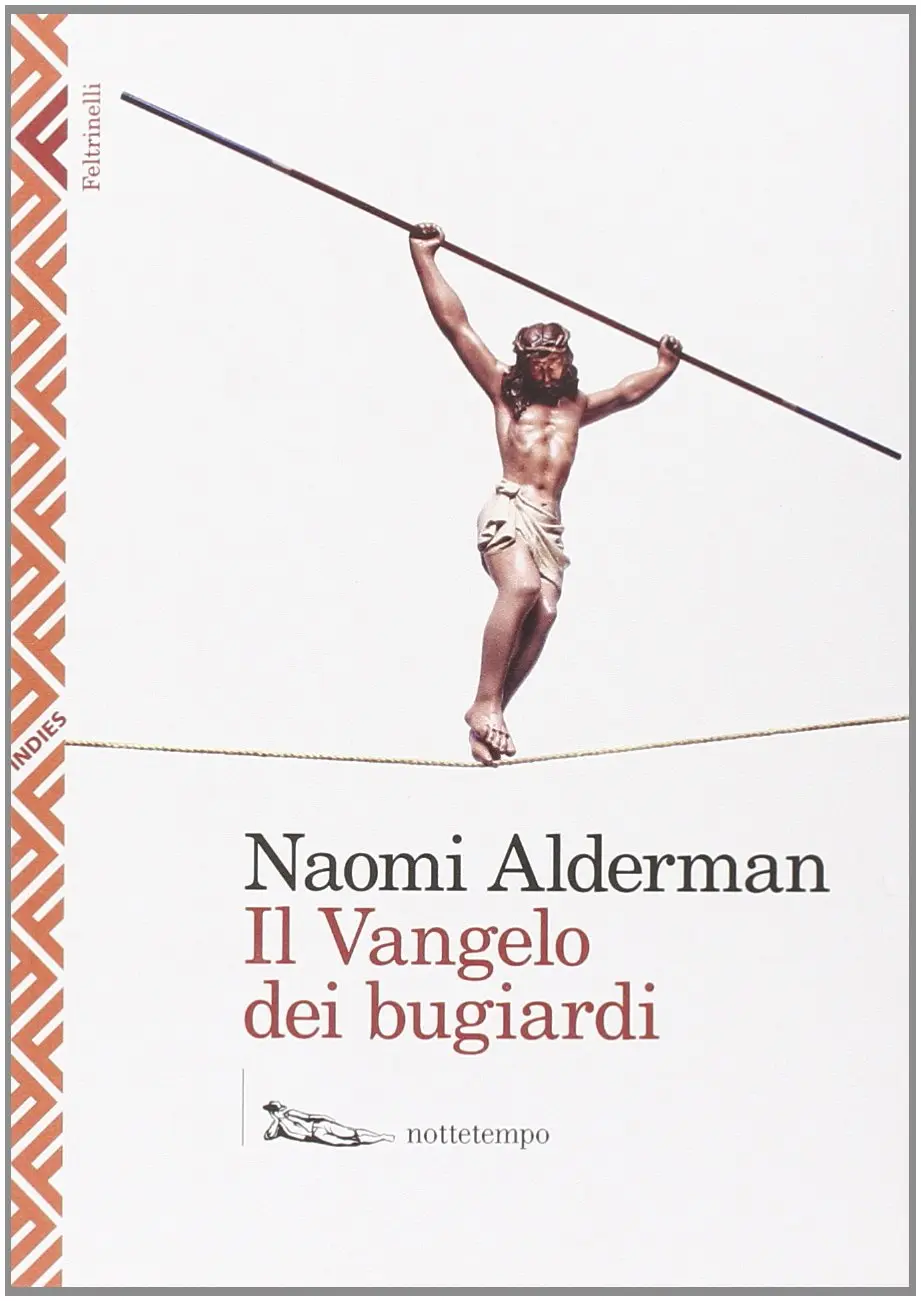
Scritto da MARIA NISII.
Data la grande proliferazione delle riscritture, è indubbio che ogni autore tenti di adottare una prospettiva propria, possibilmente insolita, scegliendo di posizionarsi in uno spazio meno frequentato, magari attraverso un nuovo punto di vista o individuando una modalità narrativa poco sfruttata.

Naomi Alderman, scrittrice inglese, vincitrice di alcuni riconoscimenti in ambito letterario, propone un vangelo quadripartito in cui questa volta si viene invitati a guardare la nota vicenda attraverso gli occhi della madre, di Giuda, Caifa e Barabba. Ciascuno racconta il suo vangelo bugiardo, che in quanto tale conterrà poco o nulla del racconto tradizionale. Le quattro versioni hanno tra loro alcuni punti di contatto, quando incontrano il personaggio del precedente vangelo, ma sostanzialmente aggiungono ogni volta dettagli a una storia che non può che risultare diversa se a raccontarla è un personaggio costruito perché non assomigli all’originale. Le quattro storie riguardano soprattutto i loro protagonisti e appena sfiorano la vicenda evangelica. Sono dunque godibili come storie; storie in cui, a un certo punto, si intreccia un’altra storia

Dei quattro vangeli “bugiardi” fisseremo l’attenzione solo sul secondo, quello di Giuda. Il traditore qui non è morto, ma tale è creduto dal gruppo a cui si è unito all’inizio della vita pubblica di Yehoshua (Gesù), che ha seguito sin da subito diventando uno degli intimi. Dopo la crocifissione, per la necessità di trovare un rifugio lontano da tutti, è diventato un protetto di Calidoro, ricco romano che in cambio gli chiede di animare le serate con i suoi ospiti, raccontando del Dio degli ebrei e dell’uomo che è stato il suo Maestro. Iehuda (Giuda) si presta a divertire il pubblico con abile eloquenza, ma mentre ripete il suo vangelo bugiardo ricorda a se stesso com’è andata «davvero» la storia in un’ampia digressione.
Dopo aver perduto la giovane moglie per febbre, stava perdendo anche il suo Dio quando nel villaggio è arrivato un predicatore. Si tratta naturalmente di Yehoshua, il quale mostra subito di conoscerne la pena: lo riavvicina a Dio, insegnandogli in modo nuovo il comandamento dell’amore. «Quell’uomo, pensò, quell’uomo infervorato e giusto, avrebbe cambiato il mondo intero» (p. 102), si dice Iehuda e da quel momento prende a viaggiare con lui, vedendo il gruppo crescere dopo ogni sosta. Il giovane però non è acritico e da subito si accorge che Yehoshua non guarisce tutti e sempre, ma solo in presenza di una grande folla e un giorno gli chiede come si producano quei prodigi: «Non so in che modo faccio quello che faccio. Quando parlo, i demoni forse ascoltano, ma ciò che accade dopo è nelle mani di Dio» (p. 107).

Iehuda non può frenare delusione e irritazione non appena si accorge che Yehoshua è convinto di essere il messia atteso. È quindi tra i tanti che seguono curiosi il gruppo che conosce Calidoro, con cui si intrattiene a sufficienza per sentirgli parlare di altri maghi incontrati che, dietro ricompensa, avevano rivelato i propri trucchi. Il dubbio si è ormai insinuato nel suo cuore e quello che continua a vedere non fa che confermarlo. Così resta sconcertato dalla risposta che Yehoshua dà all’uomo che vorrebbe seguirlo dopo aver seppellito il padre ed è disgustato dal desiderio di potere che si fa strada tra i seguaci, persuasi della gloria a cui tutto quello avrebbe condotto.

Il racconto dell’unzione, riportato nella versione lucana, risulta totalmente stravolto: qui la donna è benestante e probabilmente ubriaca, se non folle, e ogni goccia di unguento viene contabilizzata secondo il bene che non è stato fatto. La risposta che Yehoshua offre in privato alle rimostranze di Iehuda è tuttavia interessante:
«perché insisti a vedere solo con gli occhi? […] Pensi che rimarrò con voi ancora a lungo? ]…] Quando Dio stesso viene sperperato per il mondo intero, credi che importi a qualcuno che un po’ di olio sia stato versato qui per terra?» (p. 125).
Iehuda ha perso fiducia nell’amico, che invece di farsi tramite di Dio, ritiene essere un dio egli stesso. «A nessuno andrebbe detto che è un dio mentre è ancora in vita» (p. 127), sostiene Calidoro che nel frattempo ha reincontrato e che in proposito ha l’esperienza degli imperatori di Roma, di cui è suddito senza esserne succube. È così che scatta la molla del tradimento e mentre l’accampamento dei seguaci si ferma per la notte fuori Gerusalemme, Iehuda fugge al tempio per accordarsi con i sacerdoti, i quali non sembrano aver dato molta importanza al loro movimento: qualche frustata sarà una punizione sufficiente se Yehoshua dichiarerà di non accampare pretese al trono.
Al mattino dell’arresto i discepoli lottano, nonostante l’insegnamento a porgere l’altra guancia – nota Iehuda – né Yehoshua si preoccupa di fermarli. Tutti comprendono l’identità del delatore, costringendolo a seguire i soldati a Gerusalemme. Una volta arrivato al tempio però non può proseguire oltre e dopo aver ricevuto una borsa di denari, va a radersi per dissimulare la nuova identità di romano. Avvicinatosi al luogo dell’esecuzione, quello che era stato il suo amico è ormai allo stremo: «Non avrebbe riconosciuto sua madre, se fosse arrivata in quel momento» (p. 138). E quando lo vede morire è ormai persuaso che non fosse il Messia: era quella la prova che attendeva e ora sa. Qualche giorno dopo si reca alla tomba, perché avrebbe voluto seppellirlo in un luogo che gli è caro, ma il corpo nel frattempo è già stato prelevato da altri.
Finiti i ricordi personali, torna agli ospiti di Calidoro ai quali conclude la sua storia, scherzando: «forse, come l’imperatore Augusto, il mio amico si è già trasformato in un dio nel momento in cui è morto», ma poiché questi si inquietano per il paragone, aggiunge: «proprio come Augusto, che è morto nel pieno della sua maestà e ora regna lassù in piena maestà, temo che il mio amico Yehoshua si trascini ancora dietro la sua croce nell’alto dei cieli!» (p. 139). Tuttavia, consapevole di aver raccontato troppe volte quella storia e che il suo tempo lì sia giunto al termine, si congeda. In viaggio però torna a sentire la voce del Signore: «Le persone devote vorrebbero credere che Dio non si rivolga ai peccatori, che ci si debba guadagnare il diritto di udire la Sua voce. I devoti sbagliano. Dio parla a Iehuda di Qeriot così come parlava a Yehoshua di Nazareth, proprio come avrebbe parlato all’imperatore Tiberio di Roma, se quel sovrano depravato avesse avuto l’astuzia di ascoltarlo» (p. 144).

L’epilogo, con cui si spengono questi quattro riflettori bugiardi, richiama gli eventi storici, dando conto del piccolo culto che cresce per il nuovo dio, re crocifisso, rifiutato dagli ebrei che per questo sono stati puniti con la distruzione della capitale. Ma la conclusione non è più storica e sembrerebbe mettere in questione l’atto stesso del raccontare:
«I narratori sanno che ogni storia è almeno in parte una bugia. Ogni storia potrebbe essere raccontata in quattro modi diversi, o quaranta, o quattromila. Ogni sottolineatura o omissione è una specie di bugia, che plasma un momento per renderlo un fatto» (p. 276).
È un modo per parlare, narrativamente, di che cosa sia finzione, un carattere che non smentisce il contenuto di verità, senza per questo cadere in contraddizione. Una storia inventata può essere infatti vera su un altro piano rispetto alla mera riproposizione dei fatti, così come lo spostamento del punto di vista dimostra – quello dei quattro vangeli canonici, tutti diversi eppure tutti ugualmente veri, che i quattro vangeli bugiardi vorrebbero beffardamente riprodurre, nella smaccata autocertificazione di falsità. Una dichiarazione di intenti che mette a tema il relativismo prospettico, la sfiducia che una qualche verità possa risiedere nella dispersione delle prospettive e nella diversità irriducibile che rende ogni visione inconciliabile alle altre.
Una tale programma di lavoro risulta tuttavia soprattutto un gioco letterario, che fa pendant con il titolo in cui la «bugia» è elevata a unica possibilità del raccontare. All’interno del testo infatti i riferimenti alla menzogna sono troppo numerosi per essere semplici allusioni, come se ogni personaggio esibisse il carattere finzionale proprio e della storia che sta interpretando oltre che raccontando. Il primo a essere definito «bugiardo» è lo stesso Yehoshua, per bocca della madre che dal figlio si è sentita rifiutata e che ora vuole dimenticarlo. Ma uno a uno sono bugiardi tutti i personaggi, che non si rivelano per quello che sono o che non dicono quello che pensano.
Tanti dei racconti che circolano su Yehoshua e il suo gruppo sono «falsità allo stato puro oppure resoconti curiosamente distorti» (p. 84), sostiene Iehuda dopo aver ascoltato un gruppetto di donne al mercato che bisbiglia qualcosa sui discepoli dispersi dopo la morte del maestro. E lui stesso non può che essere un bugiardo per mantenersi in vita (menzogna è salvezza) nella casa di Calidoro, ma di fatto lo è già stato nel gruppo degli intimi di Yehoshua quando ha dovuto fingere di non essere se stesso, mentre desiderava stare «soltanto con una persona alla quale non dover raccontare bugie» (p. 115). Il vero non è possibile, per quanto resti un’ambizione desiderabile. Il gruppo dei discepoli non vuole udirne le parole, quando Iehuda si preoccupa del pericolo che stanno correndo: lui rappresenta il senso di realtà, gli altri il delirio della gloria-potere. E Iehuda, insieme a loro, «non riesce più a distinguere tra verità e menzogne» (p. 122). Così, tradendo, fa la sua scelta: mente per vivere nella verità, la sua, l’unica possibile. La versione passata alla storia invece, quella con il suo suicidio, è naturalmente una menzogna.

Perché leggere il vangelo di un bugiardo? Nessun lettore di fiction sarebbe disposto a dichiararsi amante della menzogna. Eppure c’è un credito che anche Naomi Alderman desidera ricevere dal suo lettore, inserendo testi di carattere «storico» nella cornice narrativa: dentro quella storia, dentro ogni storia, c’è menzogna. È questo l’unico modo possibile di raccontare. E la storia (anche la Storia) chiede di essere raccontata. Il narratore onnisciente – qui curiosamente impiegato in luogo della prima persona che meglio si sarebbe prestata all’inganno – fa penetrare il lettore nella coscienza dei suoi personaggi; e il narratore onnisciente non può che raccontare il vero perché tale è (o almeno teoricamente dovrebbe essere) lo statuto epistemologico dell’onniscienza narrativa, che è l’attendibilità. Ma qui colui che tutto sa sceglie di rivelare l’inattendibilità dei suoi personaggi e delle loro storie, seducendo il suo lettore (perché i quattro racconti sono molto coinvolgenti: ben scritti, carichi di sesso e di violenza) salvo poi abbandonarlo nel dubbio. Se si è accettato il patto, si è scelto di sospendere l’incredulità e di credere che l’unica verità possibile sia la menzogna. E allora: menzogna sia!