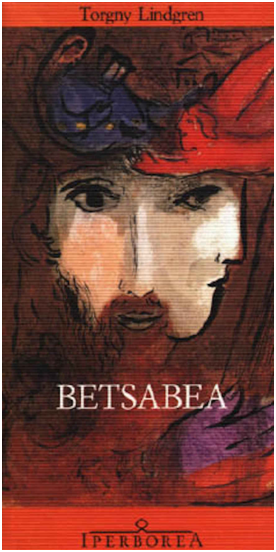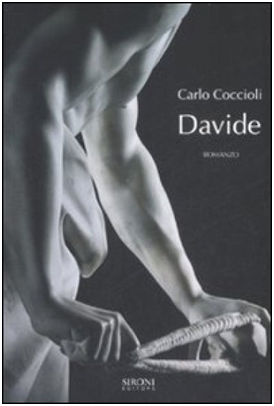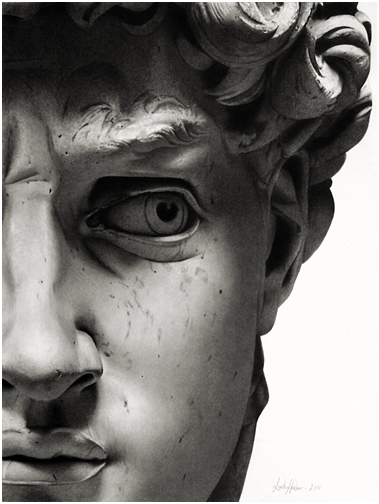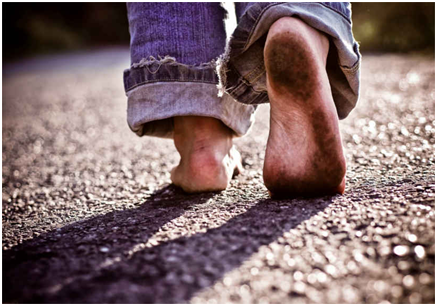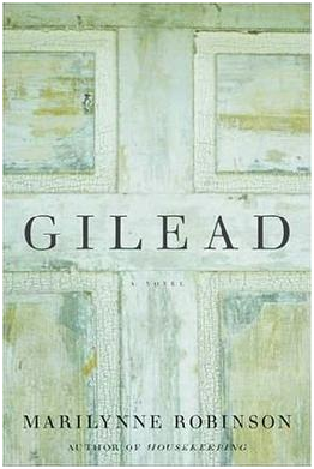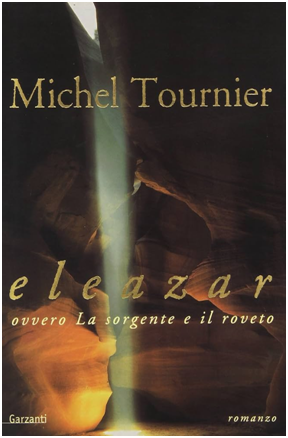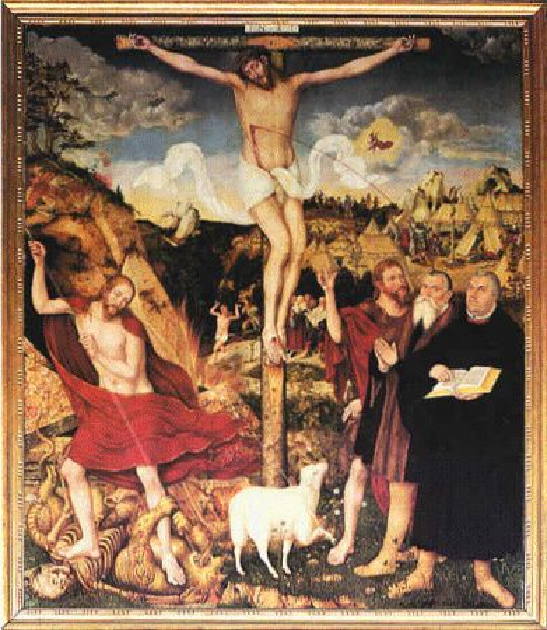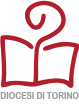Scritto da LORENZO CUFFINI.
Alla fine dei giorni,
il monte del tempio del Signore
sarà eretto sulla cima dei monti
e sarà più alto dei colli;
ad esso affluiranno tutte le genti.
3 Verranno molti popoli e diranno:
«Venite, saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci indichi le sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieri».
Poiché da Sion uscirà la legge
e da Gerusalemme la parola del Signore.
4 Egli sarà giudice fra le genti
e sarà arbitro fra molti popoli.
Forgeranno le loro spade in vomeri,
le loro lance in falci;
un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo,
non si eserciteranno più nell’arte della guerra.
5 Casa di Giacobbe, vieni,
camminiamo nella luce del Signore. (Isaia 2,2-5)
Vale sempre la pena raccontare come la riscrittura biblica non venga praticata solo nell’arte, in letteratura, in musica: ma come possa esistere anche una forma di riscrittura incarnata, per così dire, nella vita, nelle azioni, nella condotta . Succede che qualcuno la prende talmente sul serio, la Parola, da viverla in se stesso. Declinandola per conseguenza nella sua specifica realtà e nel suo mondo. Dandone così una versione attualizzata e contestualizzata, tutta sua, che sarà per forza qualcosa di nuovo e originale.
Siamo abituati a credere che questo possa accadere in pochi casi: quelli di coloro che chiamiamo “santi”, ad esempio. Ma i santi non nascono tali, con tanto di aureola incorporata: e se una larga fetta di agiografia tradizionale tende a presentarceli come predestinati e presecelti, basta accostarsi alle loro vite in modo oggettivo per cogliere tutta la normalità e tutta l’umanità di queste persone: assolutamente uguali a noi. Santi, eventualmente, si diventa. Testimoni, si diventa. Riscritture viventi del Vangelo, si diventa.
Nella Preghiera per la pace voluta da papa Francesco in San Pietro il giorno 27 di ottobre, è stata proclamata a un certo punto la profezia di Isaia che abbiamo riportato qui sopra. A dare una prospettiva e un orizzonte alla supplica della giornata , bene incentrata sui disatri, sui pericoli e sulle paure connesse all’ora buia che stiamo vivendo.
Solo poche ore dopo questa preghiera e queste parole, tutti i Tg sono andati in onda con edizioni starordinarie che annunciavano un incremento di violenza, di bombardamenti, in una parola di guerra, come non si era mai visto dall’inizio di questa crisi. Il che ci ha fatto toccare con mano, ci ha fornito l’ennesima prova provata di quanto le parole della fede e della preghiera possano sembrare lontane, svuotate, irrealistiche e – vogliamo dircelo ?- sostanzialmente inutili davnti allo scatenarsi della furia bellica.
Eppure la Parola è quella, ed è parola di Dio, se ci si crede.
A noi tocca ascoltarla, meditarla, pregarla. E poi? Poi: ci tocca riscriverla nelle nostre vite. Pena il renderla inerte, vana, veramente inutile, questa Parola che ci è data. E saremo noi ad averla sabotata e ad averla fatta abortire: con il nostro nulla fare.
Due brevi vademecum per l’occasione.
“ La reazione impulsiva di chiudersi a riccio, blindandosi per paura del “diverso” che vive in mezzo a noi, serve a poco o nulla. Sentirsi in guerra in modo permanente, cercare la contrapposizione frontale tra civiltà e religioni, sarebbe abboccare all’amo: proprio questo cercano. C’è un piano su cui si muovono e debbono agire i politici, le polizie e gli eserciti . Noi possiamo influirci poco o niente. Ma ce n’è un altro, non meno importante, che è quello culturale, sociale e di mentalità, dove è indispensabile fare un gran lavoro paziente , tenace e prolungato nel tempo. Lì, noi possiamo fare tanto. Tocca a noi. Basta, col rinchiudersi in salotto, a lanciare accuse o profezie di sventure: tocca schiodarsi dalle poltrone e andare fuori. Basta, col salire sulle barricare del ” noi cattolici”, contro tutto quello che non lo è: bisogna farsi elemento di unione, collaborazione, far fronte comune con tutti gli altri per cercare e portare avanti ogni forma possibile di integrazione e coesistenza pacifica tra culture e religioni. C’è da farsi un bel mazzo. Che però passa dalle nostre parole, dai nostri piccoli gesti, dalle nostre chiacchiere da bar, dai nostri interventi pubblici, dal nostro essere presenti nelle piazze, dai nostri pareri, dal nostro modo di vivere e di comportarci .A patto che ci si voglia mettere la faccia , la testimonianza e il “giorno per giorno”.” ( Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino, 30 marzo 2016)
La violenza, la guerra, ” il terrorismo, di qualunque matrice esso sia, è una scelta perversa e crudele, che calpesta il diritto sacrosanto alla vita e scalza le fondamenta stesse di ogni civile convivenza. Se insieme riusciremo ad estirpare dai cuori il sentimento di rancore, a contrastare ogni forma di intolleranza e ad opporci ad ogni manifestazione di violenza, freneremo l’ondata di fanatismo crudele che mette a repentaglio la vita di tante persone, ostacolando il progresso della pace nel mondo. Il compito è arduo, ma non impossibile. Il credente infatti sa di poter contare, nonostante la propria fragilità, sulla forza spirituale della preghiera.
Cari amici, sono profondamente convinto che dobbiamo affermare, senza cedimenti alle pressioni negative dell’ambiente, i valori del rispetto reciproco, della solidarietà e della pace. La vita di ogni essere umano è sacra sia per i cristiani che per i musulmani. Abbiamo un grande spazio di azione in cui sentirci uniti al servizio dei fondamentali valori morali.
Quante pagine di storia registrano le battaglie e le guerre affrontate invocando, da una parte e dall’altra, il nome di Dio, quasi che combattere il nemico e uccidere l’avversario potesse essere cosa a Lui gradita. Il ricordo di questi tristi eventi dovrebbe riempirci di vergogna, ben sapendo quali atrocità siano state commesse nel nome della religione. Le lezioni del passato devono servirci ad evitare di ripetere gli stessi errori. Noi vogliamo ricercare le vie della riconciliazione e imparare a vivere rispettando ciascuno l’identità dell’altro. La difesa della libertà religiosa, in questo senso, è un imperativo costante e il rispetto delle minoranze un segno indiscutibile di vera civiltà”. ( Benedetto XVI, Colonia, 2005)
C’è dunque una riscrittura che attende ciascuno di noi.
Il posto di spettatore , per quanto angosciato, ci è precluso.
Se siamo qui, è perché siamo stati scelti, mandati.
Credenti, missionari, testimoni: ma anche – e in questi momenti soprattutto – PROFETI
Non a parole: non sta a noi.
A noi tocca la profezia nei piccoli fatti della nostre storie.
___________________________________
- Le citazioni sono tratte da : https://www.diocesi.torino.it/cultura/una-canzone-originale-per-il-concerto-dell8-aprile-al-santo-volto/