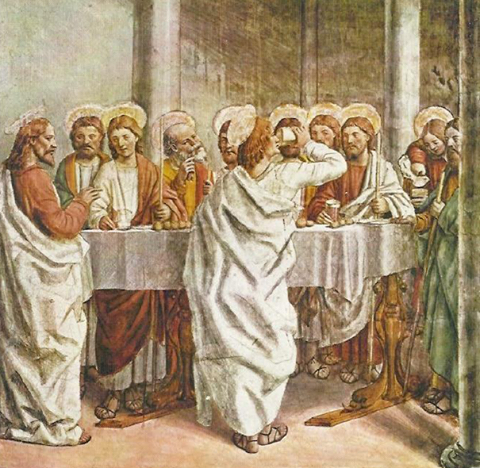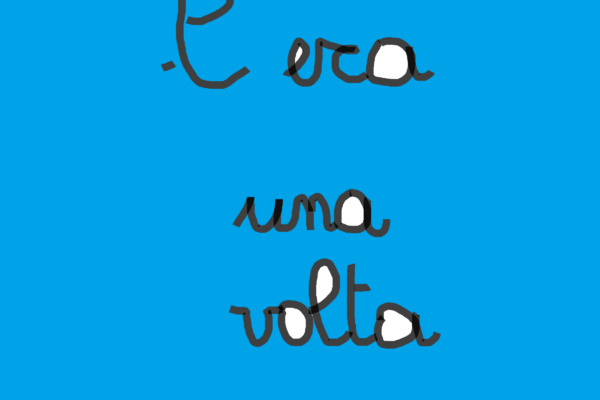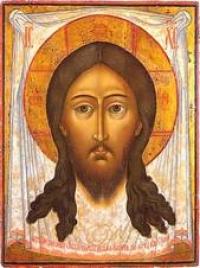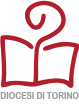Scritto da Gian Luca CARREGA.
Le tecniche narrative della Bibbia sono per loro natura essenziali perché si tratta di un libro che raccoglie delle storie prevalentemente didattiche e quindi non si soffermano su dettagli che possano distogliere l’attenzione o su trame troppo complesse che perdano di vista l’obiettivo catechetico. I narratori adottano spesso quelle regole basilari che normano anche i racconti orali più semplici e tra queste c’è senza dubbio la legge del tre. È un procedimento molto elementare che prevede una sequenza di tre esempi: il primo rappresenta una posizione, il secondo la conferma e il terzo la smentisce. Chiunque di noi si è imbattuto da bambino nella famigerata serie delle barzellette del francese, dell’inglese e dell’italiano. Il tema della barzelletta poteva variare, ma la struttura era sempre la medesima: un problema che né il francese né l’inglese riuscivano a risolvere veniva brillantemente superato dal genio dell’italiano. La narrazione biblica conosce diversi esempi di questa struttura ternaria già nei racconti più antichi. All’inizio del secondo libro dei Re il sovrano di Israele, Acazia, vuole consultare il profeta Elia e lo manda a prendere attraverso un comandante con cinquanta uomini che gli riferisce la convocazione in modo arrogante. La reazione del profeta è l’invio di un fuoco dal cielo che incenerisce tutta la delegazione. L’episodio si ripete tale e quale con una seconda delegazione. Quando il re invia una terza ambasciata, il comandante “cadde in ginocchio davanti a Elia e lo supplicò” (2Re 1,13). Con un po’ di pazienza e la carbonizzazione di cento persone il profeta riuscì a insegnare le buone maniere.
Anche nelle parabole di Gesù è frequente imbattersi nella legge del tre. Si prenda la parabola dei talenti (Mt 25,14-30) o delle mine (Lc 19,11-27). Un padrone affida una prebenda a tre servi, due dei quali la fanno rendere, sebbene in maniera diversa, mentre il terzo non combina nulla. Oppure si esamini la parabola dei vignaioli omicidi (Mc 12,1-9 e paralleli), dove per due volte vengono inviati dei servi per riscuotere l’affitto e dopo il loro fallimento il padrone decide di inviare un ambasciatore di altro genere, il proprio figlio. Ma l’esempio più significativo si trova nella parabola del Buon Samaritano (Lc 10,30-35). Sulla strada da Gerusalemme a Gerico sfilano tre persone davanti a un moribondo, due personaggi legati al culto e un samaritano, ma soltanto una si ferma a soccorrerlo. Il terzo personaggio, ovviamente.