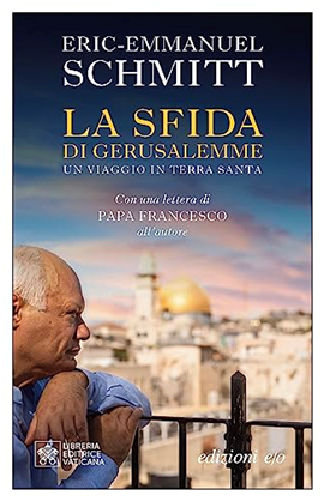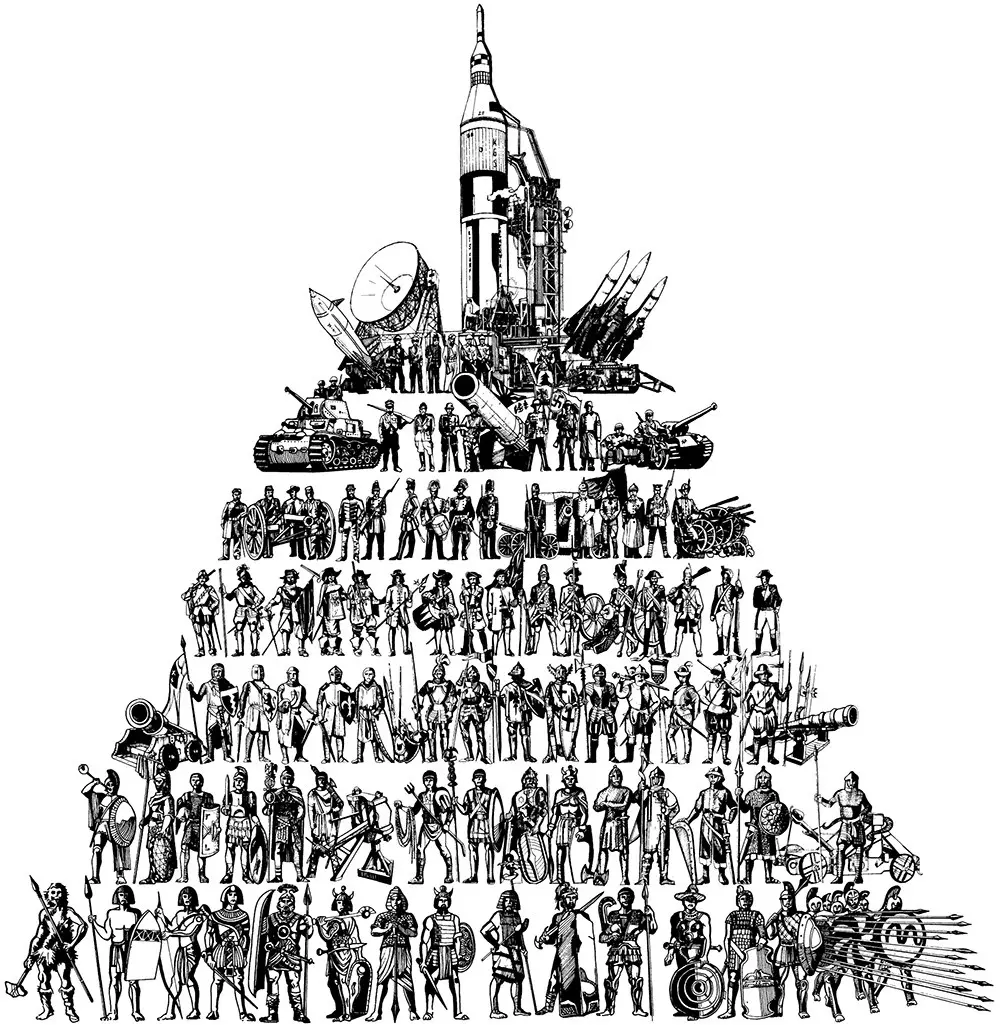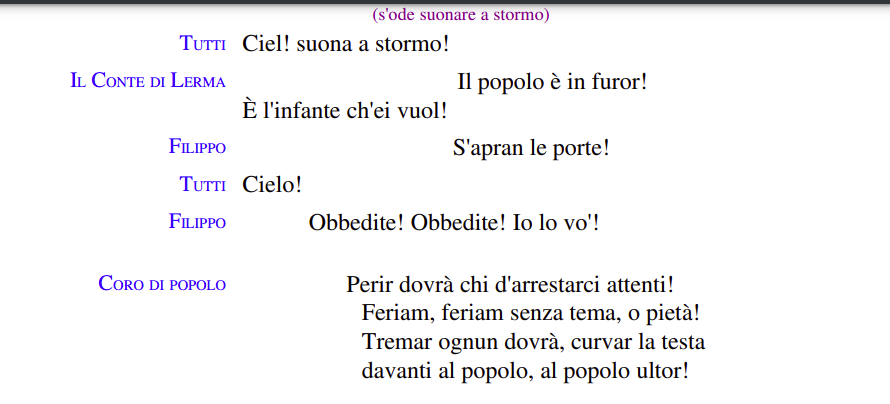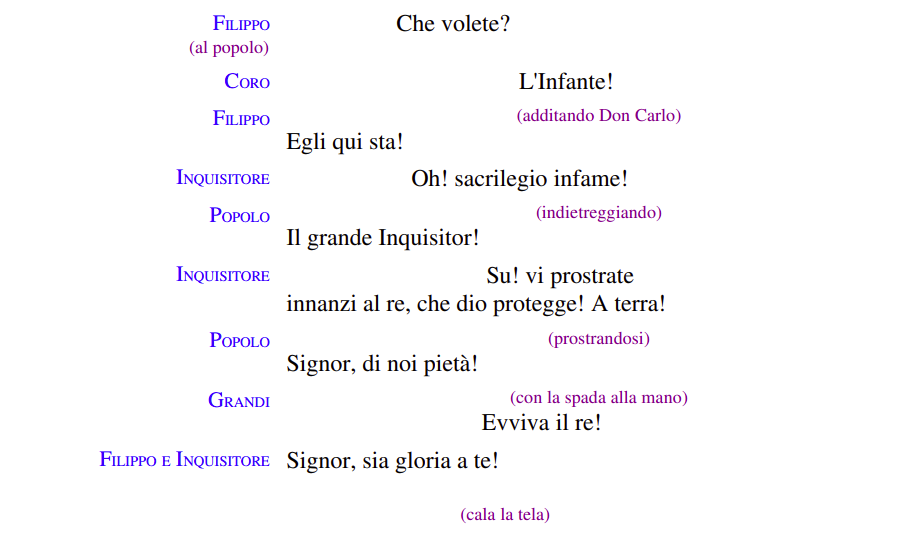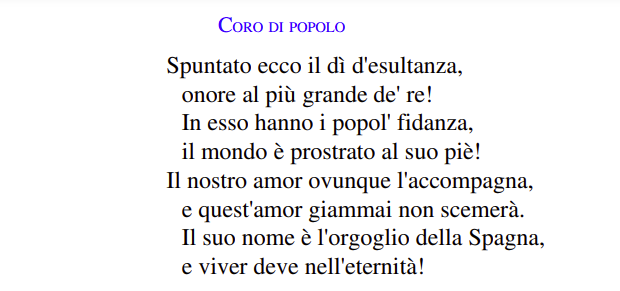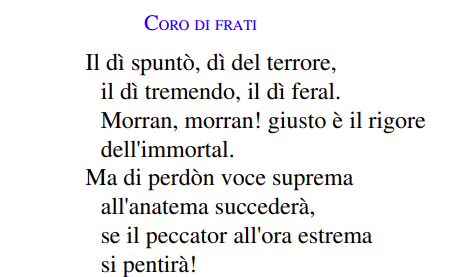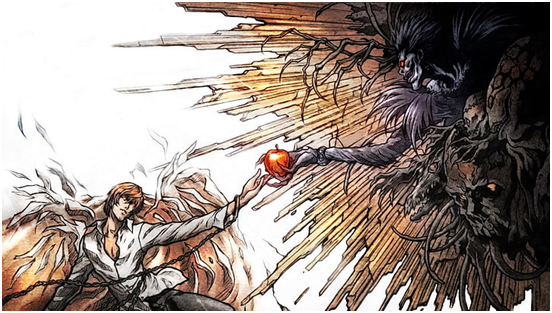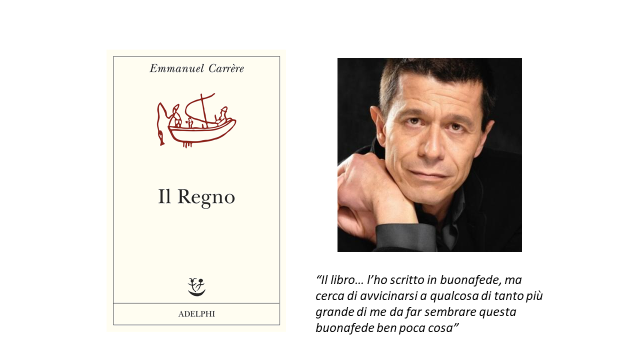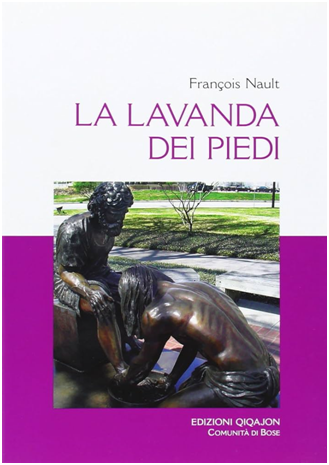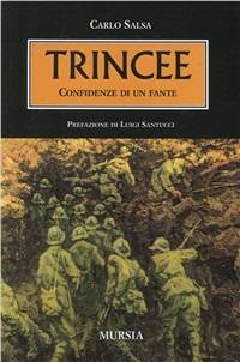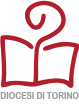Scritto da LORENZO CUFFINI.
Care amiche e amici lettori,
con la fine di questo anno solare termina anche l’avventura di questo blog.
E’ stato un viaggio abbastanza lungo, cominciato il 28 marzo del 2016 per accompagnare la pubblicazione dei volumi della collana Scrittori di Scrittura, ma col tempo ha finito con l’assumere una sua fisionomia autonoma. Che poi in realtà è il riflesso delle diverse personalità che vi hanno contribuito e questo testimonia a favore della sua genuinità, perché quando le persone hanno la possibilità di condividere le loro passioni succede sempre qualcosa di bello. Così nel tempo si sono accumulati 410 post, che sono una bella cifra e spaziano sui diversi ambiti in cui la Scrittura ha trovato risonanza.
Per noi è stato bello poter partecipare a questa iniziativa e colgo l’occasione per rinnovare i miei ringraziamenti a tutti quelli che hanno pubblicato il frutto dei loro sforzi e hanno avuto l’audacia di condividerlo sulla rete. L’editore Effatà ha reso possibile questa operazione acquistando lo spazio per ospitare queste riflessioni e merita il nostro plauso. Ma soprattutto vorrei ringraziare voi che ci avete seguiti in questi anni: abbiamo cercato di incuriosirvi e di trovare qualche spigolatura nuova che permettesse di comprendere meglio testi che continuano a parlarci a distanza di secoli e speriamo di esserci riusciti almeno in parte. Il profeta Isaia ci ricorda che l’erba si secca e il fiore appassisce, ma la Parola rimane in eterno. Anche se questa compagnia si scioglie, il viaggio della Scrittura continui per ciascuno di voi! (don Gian Luca Carrega)
Viaggiando in rete, mi sono imbattuto l’altro giorno in un post dell’amica scrittrice torinese Desy Icardi che a proposito dell’anno giunto agli ultimi, così si esprime: Nulla di personale, ma vattene senza voltarti…Questo andarsene senza voltarsi indietro, mi ha richiamato alla mente la vecchia, cara storia di Orfeo ed Euridice: il mito per eccellenza che, detto in soldoni, si occupa di fine, di rimpianto, di eccessivo amore, di impossibilità di riportare indietro le cose a piacimento. Tutta roba che casca a fagiolo in sede di chiusure & bilanci. Da qui a saltare su una riscrittura particolarissima di quello stesso, famosissimo mito, il passo è stato quasi istantaneo.

Sto parlando di Orfeo9 : poco nota, ma assolutamente degna di menzione, si tratta della prima opera rock italiana, datata 1970, a firma di Tito Schipa jr, e di cui possediamo una versione teatrale, un film e un disco ( per i patiti, decisamente cult). In rete si trova abbondante materiale, ed è anche possibile fruire della visione integrale del film ( peraltro trasmesso nel mese di dicembre 2023 a più riprese ed in diversi orari da Rai5 e disponibile su Raiplay ). Chi volesse farsene una idea più precisa e completa, ne ha dunque la possibilità, con la comodità aggiuntiva di poterlo fare in santa pace a domicilio.
Qui ci si limita a citare la chiusa dell’opera, ECCOTI ALLA FINE, parafrasata appunto nel titolo dell’articolo. Naturalmente sono parole che si riferiscono alla storia raccontata, ma sono cariche di echi e vibrazioni che ben si adattano a una situazione di conclusione e di passaggio come è la nostra in questi giorni.
“Eccoti alla fine e come tutte le fini ha uno strano sound”
Credo che ben rappresenti, pur parlando di tutt’altro, quello che quanti hanno messo mano a questo blog hanno sperimentato e cercato di esprimere. Chiunque si avvicini a una riscrittura biblica – credo che lo abbiamo dimostrato nei nostri quattrocentodieci esperimenti – si trova a che fare sì con la Scrittura vera e propria, ma solo come nocciolo di partenza; per il resto fronteggia le immagini, i suoni, le storie, le suggestioni, l’ispirazione, l’eco, che la Scrittura stessa ha generato nel riscrittore, sia esso diretto o indiretto. Quel che ne deriva ( la ri-scrittura appunto) è qualcosa di autonomo ed indipendente, talvolta anche lontano, in certi casi sprigionato inconsapevolmente da un racconto o una situazione che assumono accenti di riscrittura solo all’orecchio del credente…” Hai sparso le tue note sul sentiero come nella favola. Ma il sentiero non ritorna indietro, adesso chi le coglierà? “
“Hai creduto il mare popolato d’ombre per l’eternità…Hai sognato in viaggio che al di là del bosco fosse l’aldilà” mi pare che renda bene la situazione che abbiamo attraversato e che abbiamo tentato di farvi attraversare. Per cui, ora che questa esperienza si conclude, che questo viaggio giunge alla sua fine, le parole di questo brano risuonano al nostro animo come rivolte da noi alla Scrittura stessa: ” Solo da te verrà verrà il sorriso, il vero paradiso, tu sei il paradiso in terra e nessuno lo sa. Solo per te stasera canto, non mi importa di aver pianto, guarda, ascolta sono qui: sto cantando per te, per te, per te.”
Utilizzando la abusata ma sempre efficace metafora del dito e della luna, i riscrittori e coloro che li raccontano sono il dito, laddove la luna, immutabile, splendida, misteriosa e sempre soprendente, è la Scrittura. Il dito, in questi sette anni, ha cercato in moltissimi modi diversi di appuntarsi su piccoli e grandi aspetti del Lunone: ” Uomo, lo so che lei nasconde il viso: si fa più in là, ogni volta che con l’ombra della tua mano, col velo del tuo respiro, cerchi Amore“. La speranza è che in qualcuno sia nato, per curiosità o per contagio, il desiderio di considerare la Scrittura qualcosa di vivo adesso, di vivo per ciascuno di noi, protagonista nelle nostre vite, e come tale trattabile e raccontabile anche al di fuori delle aule di teologia e del luoghi venerandi di preghiera. Perché quello che abbiamo capito è che, in potenza, tante sono le riscritture di Scrittura quanti sono i suoi ascoltatori, se solo la ascoltano disarticolando l’abitudine, tirandola giu’ dai piedistalli, andando oltre la devozione, molto bella e santa, che tuttavia molte volte congela e sterilizza.
” Uomo…Guarda più avanti. Avanti è l’avventura. Scorda il passato, scorda la paura, scorda la gioia che non è matura, anche la gioia se non ti assicura vita vera, cara, cara...”
Buona avventura a tutti.
(…e una dedica e un ringraziamento speciali a Giovanni Flecchia, “titoschipomane” della prima ora).
_________________________
- In copertina, una citazione da THE END, The Doors